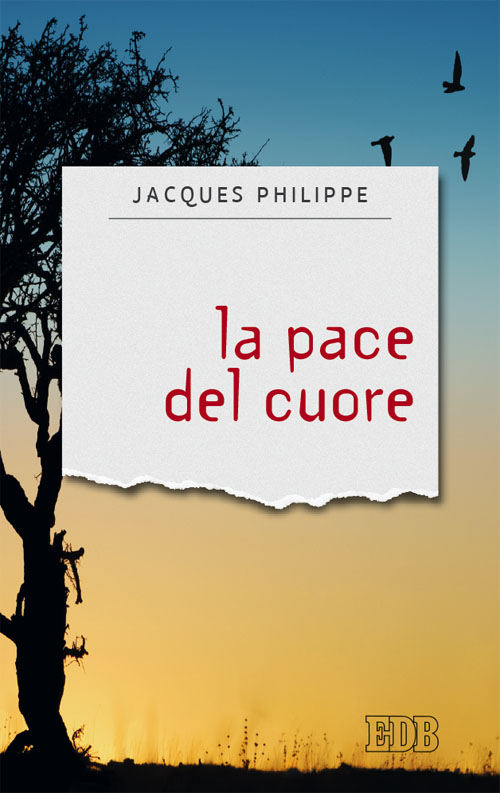
La paix intérieure, une urgence spirituelle
Sommaire
- 1 L’appel à se laisser pacifier.
- 2 La paix intérieure, promesse divine.
- 3 Pourquoi chercher la paix intérieure ?
- 4 Un long travail de réconciliation.
L’appel à se laisser pacifier.
« Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l’attente de ce jour, frères bien aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve nets et irréprochables, dans la paix. » (2 P 3, 13-14)
En conclusion d’un passage qui évoque la venue du Jour du Seigneur à la fin des temps, et utilise les images de l’apocalyptique traditionnelle, il est remarquable que saint Pierre nous exhorte à ce que ce Jour « nous trouve en paix ». Non pas dans l’angoisse ou la peur, mais dans la paix.
Nous ne devons évidemment pas spéculer sur la fin des temps, seul le Père connaît le jour et l’heure ; mais il me semble qu’il y a là un enseignement fondamental pour aujourd’hui : plus l’Eglise et le monde vont vers leur achèvement, plus la création gémit dans les douleurs de l’enfantement, plus le chrétien est invité à être en paix. Plus le monde traverse des crises, plus la société est marquée par des tensions et des insécurités, plus il est nécessaire de trouver la paix véritable, de se laisser en profondeur pacifier par le Christ.
Je crois qu’il a là une urgence spirituelle. Plus l’Eglise avance dans sa marche dans l’histoire, plus elle est appelée à vivre chacune des Béatitudes, et tout spécialement la septième : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».
Il y a donc un appel très fort à nous laisser pacifier par le Christ, à accueillir dans notre cœur la paix de Dieu. J’irais jusqu’à dire que le premier devoir d’un chrétien, ce n’est pas d’être parfait, ni de résoudre tous ses problèmes, c’est d’être en paix. Je rejoins tout à fait Etty Hillesum quand elle s’exprimait ainsi en 1942: « Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition.[1] »
Si mon cœur n’est pas pacifié, je serai vulnérable à toutes les forces de divisions, à toutes les spirales de peur et de violence qui agitent le monde. Tout ce qui n’est pas pacifié en moi donne prise au mal, est comme une porte ouverte au démon, aux forces de dissociation par lesquelles il veut entraîner le monde à sa perte. Cela s’est vérifié trop souvent dans l’histoire du XXe siècle : on a vu de nombreuses personnes, que ce soit en Europe ou au Rwanda, soit disant bonnes chrétiennes, parfois mêmes engagées dans l’Eglise, entraînées à commettre des choses, des actes de violence ou de lâcheté, dont elles n’auraient jamais pensé être capables. La raison profonde en est que, quand le cœur de l’homme n’est pas vraiment pacifié par Dieu, quand il est encore habité par des peurs, des mécanismes de défenses, et qu’il se trouve plongé dans un contexte où le mal se déchaîne, où la violence, la haine, les attitudes partisanes se répandent, où la pression sociale devient de plus en plus forte, il devient incapable de résister et se laisse entraîner à commettre le mal. A certains moments de l’histoire, la bonne moralité ne suffit plus…
Nous devons donc nous tenir prêts, comme le dit Jésus dans l’Evangile, car nous ne savons ni le jour ni l’heure. Pour moi, un aspect essentiel de cette vigilance spirituelle est de veiller sur notre cœur, et de l’éduquer à demeurer, quoi qu’il arrive, dans la paix de Dieu.
Il est remarquable que, parmi les Béatitudes présentées par l’Evangile de saint Matthieu, celle des artisans de paix soit la septième. Le chiffre sept indique un achèvement, une plénitude, un couronnement. L’homme des Béatitudes rayonne la paix. Dans la liturgie eucharistique latine, le mot « paix » se trouve sept fois entre le Notre Père et la communion. L’eucharistie est par excellence un lieu de pacification du cœur, de repos en Dieu.
Si nous empruntons le chemin des Béatitudes, celui de la pauvreté spirituelle et de toutes ses expressions (douceur, affliction, faim et soif de justice, miséricorde, pureté du cœur), le fruit en est la paix du cœur, qui nous permet de devenir artisans de paix autour de nous, et de mériter le titre si beau de Fils de Dieu. Et seule l’acquisition de cette paix permet de vivre la huitième béatitude, autrement dit de recevoir la persécution comme un bonheur et non une disgrâce.
La paix intérieure, promesse divine.
Acquérir la paix, même si cela exige un long travail, est davantage l’accueil d’une promesse qu’un exercice d’ascèse. Le long discours de Jésus après la cène dans l’Evangile de Jean, est très significatif à cet égard. Il commence ainsi, au début du chapitre 14 : « Que votre cœur ne se trouble pas ! ». Un peu plus loin on y trouve ces mots : « Je vous laisse ma paix, c’est ma paix que je vous donne, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne s’effraie. » La paix promise par Jésus n’est pas celle du monde (la tranquillité de celui pour qui tout va bien, dont les problèmes sont résolus et les désirs satisfaits, paix somme toute assez rare…) ; elle peut être reçue et expérimentée même dans les situations humainement catastrophiques, car elle a sa source et son fondement en Dieu. A la fin du chapitre 16, juste avant la prière sacerdotale, adressée au Père, les derniers mots de Jésus aux disciples sont les suivants : « Je vous ai dit toutes ces choses, pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J’ai vaincu le monde. » Comme si le but ultime de toutes les paroles de Jésus, son testament spirituel, était d’établir le croyant dans la paix.
Notre paix ne vient pas du monde, des circonstances extérieures. Elle vient de notre communion de foi et d’amour avec Jésus, le Prince de la Paix. Elle est un fruit de la prière. Dieu est un océan de paix, et chaque fois que, par la prière, nous sommes en union intime avec lui, notre cœur retrouve la paix. C’est parfois une urgence et un devoir de prier jusqu’à ce que la paix revienne. Je pense que cette expérience de la prière comme lieu de pacification est un des critères de discernement de l’authenticité de notre vie de prière. Peu importe que notre prière soit pauvre et aride, du moment qu’elle porte des fruits de paix. Si, au contraire, elle n’a pas cet effet, il y a lieu de se poser des questions.
Un des beaux textes de l’Ecriture où nous trouvons cette promesse de la paix (ils sont nombreux) est le passage de la lettre aux Philippiens : « Le Seigneur est proche. N’entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l’oraison et à la prière, pénétrées d’action de grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu ; Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ Jésus. » [2]
Pourquoi chercher la paix intérieure ?
La quête de la paix intérieure est bien plus que de la recherche de la sérénité psychologique (qui n’est pas à mépriser, et qui est tellement désirée aujourd’hui ; il est bien rare qu’une publicité pour une tisane ou un week-end avec spa ne vous la promette pas…). Il s’agit d’autre chose : de s’ouvrir à l’action de Dieu. Il faut comprendre une vérité simple mais de grande portée spirituelle : plus nous tendons vers la paix, plus la grâce de Dieu est en mesure d’agir dans notre vie. Comme un lac tranquille reflète parfaitement le soleil, ainsi un cœur paisible est réceptif à l’action et aux motions de l’Esprit. « Le démon fait tous ses efforts pour bannir la paix de notre cœur, parce qu’il sait que Dieu demeure dans la paix et, c’est dans la paix qu’il opère de grandes choses »[3]. Saint Français de Sales dit de même à une de ses dirigées: « Parce que l’amour ne loge que dans la paix, soyez toujours soigneuse de bien conserver la sainte tranquillité de cœur que je vous recommande si souvent. »[4] Seul un cœur paisible est capable d’aimer vraiment.
S’efforcer de conserver la paix de notre cœur, lutter contre l’inquiétude, le trouble, l’agitation d’esprit, sont des conditions indispensables pour laisser Dieu agir, et ainsi grandir dans l’amour, et donner à notre vie la fécondité à laquelle nous sommes appelés. Saint Seraphim de Sarov n’hésitait pas à dire : « Acquiers la paix intérieure et une multitude trouvera le salut auprès de toi. »
Ajoutons que c’est seulement dans la paix que nous avons un bon discernement. Quand nous ne sommes pas dans la paix, quand nous sommes habités par le trouble, l’inquiétude, l’agitation, nous sommes alors le jouet de nos émotions, et nous n’avons pas une représentation objective du réel, nous sommes tentés de voir tout en noir et de remettre tout en cause dans notre vie. Par contre, quand nous sommes dans la paix nous y voyons clair. Saint Ignace de Loyola l’avait bien compris, en distinguant dans la vie spirituelle les périodes de « consolation et de « désolation », et en invitant à ne pas prendre de décisions engageant sa vie dans ce dernier cas, mais à rester fidèle à ce à quoi on s’était déterminé lors de la dernière période de paix.
Nous devrions en déduire cette règle de conduite : quand un problème quelconque nous a fait perdre la paix, l’urgence n’est pas de résoudre le problème dans l’espoir de retrouver ensuite la paix. L’urgence est de retrouver d’abord un minimum de paix, et de voir alors ce que nous pouvons face à ce problème. Nous éviterons des choix hâtifs et précipités, gouvernés par la peur, et ne chercherons pas à résoudre à tout prix les problèmes face auxquels nous demeurons impuissants, ce qui arrive souvent. Comment retrouver ce minimum de paix ? Essentiellement par la prière, l’écoute de la Parole, les actes de foi et de confiance en Dieu qui ne saurait nous abandonner.
Un long travail de réconciliation.
Pour acquérir la paix intérieure, outre les actes « ponctuels » à poser dans les moments de combat, que je viens d’évoquer, il est nécessaire aussi de se livrer à un travail plus en profondeur, qui résume en fin de compte toute la vie chrétienne. Ce travail implique une prise de conscience de tout ce qui n’est pas pacifié en nous, et une ouverture à la grâce, un cheminement simultané de guérison et de conversion, qui nous permette d’être de moins en moins le jouet des circonstances extérieures ou de nos blessures, et de trouver en Dieu une plus grande stabilité. Il y a là un vaste chantier, sur lequel nous ne pouvons donner que quelques pistes dans ce bref article.
Il est intéressant de remarquer que le mot « paix » dans la tradition hébraïque, s’il désigne en premier lieu ce qui s’oppose à la guerre, a aussi le sens d’achèvement, de plénitude, d’abondance. Est en paix celui qui peut dire, comme le psalmiste : « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ».[5] Le contraire de la paix devient alors le manque, la frustration, le vide, l’insatisfaction. Les deux significations se rejoignent : ce sont la plupart du temps nos manques, nos frustrations qui nourrissent nos conflits avec les autres. Nous ne supportons pas les autres parce que nous ne nous supportons pas nous-mêmes.
Rien ne s’oppose autant à la paix biblique que le vide intérieur, l’insatisfaction engendrée par une vie privée de sens. L’homme est appelé à un bonheur, destiné à une plénitude, fait pour être comblé, et ne supporte pas le vide. On voit bien dans le monde d’aujourd’hui combien le vide spirituel peut être destructeur : il engendre la violence, ou bien des attitudes dépressives, ou bien encore des recherches frénétiques de compensation. L’homme moderne est menacé plus que jamais par toute une série de comportements addictifs (sexe, alcool, drogue, internet, nourriture…), qui ont le plus souvent comme point de départ la tentative illusoire de combler un manque.
Remarquons aussi que, si la paix s’oppose au conflit, toutes les guerres ne sont pas des guerres ouvertes, des manifestations de violence ou d’agressivité ; outre les guerres offensives il y a aussi les guerres défensives : les comportements de peur, de repli sur soi, les tentatives de tout contrôler, les barrières qu’on élève pour se protéger de soi-même, des autres, de la vie. Cela aussi s’oppose à la paix biblique.
Tout ceci pour dire que l’acquisition de la véritable paix intérieure ne peut faire l’économie d’une prise de conscience et d’une ouverture à la grâce divine relativement à toutes les attitudes et les comportements (plus ou moins conscients) que je viens d’évoquer. Identifier nos agressivités, nos colères, nos haines, nos amertumes, mais aussi nos frustrations, insatisfactions, peurs, mécanismes de déni ou de défense, refus de vivre, qui sont l’expression d’un manque de paix et nourrissent les conflits dans lesquels nous nous enlisons trop souvent.
Pour classer la matière, on pourrait distinguer facilement quatre domaines dans lesquels se manifestent nos manques de paix :
La relation avec Dieu. Etre en paix avec Dieu signifie une attitude de disponibilité, de confiance, de gratitude. Alors que parfois on peut le fuir, se fermer, se méfier de lui. On peut lui en vouloir pour telle souffrance vécue, telle attente non exaucée, telle fidélité apparemment stérile. On peut se sentir indigne ou coupable devant lui.
La relation avec soi-même : ne pas s’accepter tel que l’on est, ce qui est extrêmement fréquent. Se mépriser, se juger, être perpétuellement mécontent de soi…
La relation avec autrui : peurs, fermetures, mais aussi amertumes, rancunes, pardons refusés…
Et j’ajouterais : manque de paix dans la relation avec l’existence, avec la vie. Regrets par rapport au passés, inquiétudes quant à l’avenir, incapacité à assumer la vie présente, perte du sens et du goût de ce que nous vivons…
Tout cela pour dire en conclusion que l’acquisition de la paix intérieure suppose un long travail de réconciliation : réconciliation avec Dieu, avec soi-même et sa faiblesse, avec le prochain, avec la vie. Tâche laborieuse, qui demande patience et persévérance, mais tout à fait possible, car c’est justement pour cette œuvre de réconciliation que le Christ nous est donné, lui qui est venu faire la paix par le sang de sa Croix. Réconciliant l’homme avec Dieu en lui manifestant le vrai visage du Père, il réconcilie progressivement l’homme avec lui-même, avec son prochain, avec la vie. Seul le Christ est notre paix, comme l’affirme saint Paul dans la lettre aux Ephésiens, car nous avons en lui « libre accès auprès du Père ».[6]
Père Jacques PHILIPPE
***
[1] Etty Hillesum Une vie bouleversée Collection « Points », éditions du Seuil, page 169
[2] Phil 4, 5-7
[3] Lorenzo Scupoli Le combat spirituel. Auteur du XVIe siècle qui a beaucoup influencé François de Sales.
[4] Lettre à l’Abbesse du Puy d’Orbe
[5] Ps 23,1
[6] Eph 2, 14-18




